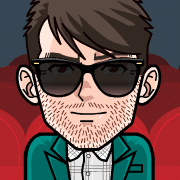A Proposito di Davis, la recensione
Ed ecco che, dopo lo splendido enigma di Serious Man e il western Il Grinta, ritornano sullo schermo i Fratelli Coen, con una storia che viene riscritta dalla parte dei vinti, o meglio, la solita storia vista dal punto di vista dei vinti.
Llewyn Davis, musicista folk di origini gallesi, conduce un’esistenza ai limiti della povertà: niente vestiti, niente soldi: solo la chitarra, e un gatto, che tra l’altro è un’amicizia che rimane in sospeso. Certo, il vero rapporto amichevole si fonda sulla gratuità, ma più che generosità relazionali, sembra che il rapporto col gatto sia venga appena schizzato – la conclusione del gatto di nome Ulisse è un pleonasmo, successivo alle serie di sventure da parte del protagonista. Davis ha di fronte e dietro di sé una serie di insuccessi, di vicissitudini, che gli mozzano completamente ogni qualsivoglia pathos (la scena della prova live dal discografico – interpretato da Murray Abraham – che, al termine della toccante esibizione del musicista, gli dice lapidario: “Non ci vedo soldi”, è uno dei picchi di cinismo del film), anche se rimangono quegli attimi di luce che sono i le sue canzoni.
Il tipico artista che fa la fame, alla deriva, che trova il riparo esclusivamente nell’esatto momento musicale (frammento molto bello del film: il musicista, ospitato da un amico antropologo, si sveglia senza sapere dove fosse fino ad un attimo prima, si siede, imbraccia la chitarra e segue il tema della musica classica che sta passando alla radio in quel momento) è interpretato dal bravo Oscar Isaac – un viso che sembra averne viste d’ogni e un’espressività di soli occhi.
A proposito di Davis, titolo omonimo del disco composto dall’autore, Inside Llewyn Davis, porta sullo schermo la splendida fotografia di colori tenui che già nel film Serious Man si faceva impronta autoriale: i colori freddi si mescolano raramente con quelli caldi, e la luce naturale dell’inverno assume tinte di inevitabilità. Simpatico Justin Timberlake, nel ruolo del tonto migliore amico di Llewyn, insopportabile Carey Mulligan nella parte della ex che deve trovarsi per casa il corpo del musicista – che spesso transita su divani: il letto spesso è un lusso.
Un film mosaico, non tanto per la sua complessità, quanto perché sembra costituito da frammenti che non hanno ancora trovato una giusta unità. La pellicola sembra essere fatta di parentesi di maestria registica, ma che spesso non trova uno scorrere unitario: molte cose rimangono irrisolte – e la poetica dei Coen del lasciare in sospeso giudizio e vicenda, imperlando le scene da un alone di mistero, è ciò che ha fatto del loro cinema una pratica originale e mai banale. Ma sfortunatamente l’unica cosa a sembrare banale in questo film, è la vicenda stessa che non genera un grosso coinvolgimento, almeno, così mi è successo.
Il vinto Llewyn Davis, circondato dal grigiore delle zone limitrofi della società, ci lascia senza un successo, senza un cambiamento o un progresso, ma ci appare un breve spaccato della sua vita, fatto di incomprensioni, sconfitte, false speranze (o forse non sono più nemmeno speranze), che non vede mai il ritorno alla sua Itaca (nessuna casa, nessun affetto, il nulla).
Poiché ciò che avviene è lo svuotamento del mondo, l’interiorità del protagonista rimane chiusa in sé, durante lo scorrere degli eventi. Incomunicabilità voluta o incompletezza estetica?